La Grande Guerra descritta in un diario di commovente drammaticità e delicatezza
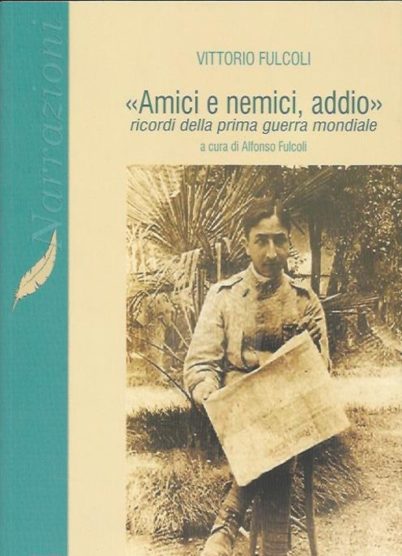 Il diario di Vittorio Fulcoli (1896-1959), racconto in presa diretta del Primo conflitto mondiale, è un libro che ho amato per diverse ragioni. Alcune di natura affettiva, ivi compresa la sua gestazione editoriale; altre invece di natura oggettiva, a cominciare dalla tecnica narrativa che ha dato vita al diario stesso. Fin dalle prime pagine infatti ci si accorgerà che l’autore, chiamato alle armi col grado di caporale, pur non faticando a capire l’eccezionalità dell’evento che lo vede coinvolto, pur percependo cioè la dimensione mondiale del conflitto, sceglie consapevolmente di “isolarsi”, affidando a una carta di fortuna il suo personalissimo modo di intendere gli uomini e le cose che lo circondano. Dando allora per scontata l’esistenza di una Grande Guerra, presupponendo l’idea degli Stati nazionali in conflitto e di un ordine geo-politico messo in discussione, egli si concentra principalmente su se stesso, fino a trasformare il suo resoconto bellico in una chiave interpretativa – oggi assai importante – per leggere e capire il mondo che lo ha prodotto.
Il diario di Vittorio Fulcoli (1896-1959), racconto in presa diretta del Primo conflitto mondiale, è un libro che ho amato per diverse ragioni. Alcune di natura affettiva, ivi compresa la sua gestazione editoriale; altre invece di natura oggettiva, a cominciare dalla tecnica narrativa che ha dato vita al diario stesso. Fin dalle prime pagine infatti ci si accorgerà che l’autore, chiamato alle armi col grado di caporale, pur non faticando a capire l’eccezionalità dell’evento che lo vede coinvolto, pur percependo cioè la dimensione mondiale del conflitto, sceglie consapevolmente di “isolarsi”, affidando a una carta di fortuna il suo personalissimo modo di intendere gli uomini e le cose che lo circondano. Dando allora per scontata l’esistenza di una Grande Guerra, presupponendo l’idea degli Stati nazionali in conflitto e di un ordine geo-politico messo in discussione, egli si concentra principalmente su se stesso, fino a trasformare il suo resoconto bellico in una chiave interpretativa – oggi assai importante – per leggere e capire il mondo che lo ha prodotto.
Come una “narrazione di sé” possa diventare la radiografia di un conflitto lo dimostra, in particolare, un’annotazione datata 3 novembre 1918, giorno dell’armistizio di Villa Giusti. In essa colpisce il fatto che, soltanto alla fine del racconto, il lettore comprende di aver assistito a una delle più cruenti battaglie che ebbero luogo sull’Altopiano dei Sette Comuni, nei pressi del forte di Punta Corbin. Questa la sequenza narrativa: Vittorio Fulcoli si alza di buon mattino per portare a termine uno dei numerosi incarichi militari caratterizzati – si sa – da mille inciampi; inciampi tanto fisici (come il faticoso attraversamento di orribili strade, di spianate ghiacciate o di ripe scoscese) quanto morali, etici (come la necessità di “dimostrarsi sordo ai rumorosi brontolii della coscienza”). L’adempimento fedele e scrupoloso del patrio compito, però, conduce il caporale direttamente nel mezzo di una “lotta selvaggia”. Prevalgono, nella descrizione di questa, le disperate note di solitudine, di sopraffazione, di abbandono. Sotto accusa viene ad essere il tradimento degli amici, chiamati per la verità sempre fratelli: come è possibile che essi assistano passivi alla fine di un commilitone? come può l’amico trasformarsi in uno spettatore trasognato e strafottente? che fine fanno, sul campo di battaglia, la solidarietà, il sentimento nonché gli ideali di patria e di giustizia? La risposta è tutta racchiusa nell’efficacia espressiva di una chiosa esemplare: “Uomini, cose, fratelli che avete assistito al mio martirio, ricordate che qui le tragedie sono tutte uguali!”.
 È uno dei tanti ammonimenti disseminati nel diario, che l’autore forgia attraverso un continuo intreccio tra effimera inconsapevolezza e cattivo presagio. Non a caso le pagine del diario si aprono con la descrizione di una gioia puerile (quella prodotta dall’anticipata chiusura delle scuole dopo l’annuncio dell’entrata in guerra dell’Italia nel maggio 1915) contrapposta al presentimento di un destino incerto. Saranno i “sensi dell’uomo” a registrare un patrimonio immenso di affetti e sentimenti, al quale si dovrà più volte attingere durante la permanenza al fronte. I sapori, gli odori, le forme, i colori e le voci dell’infanzia – ripercorsi in tutta fretta la notte prima dell’addio – costituiranno il parametro principale cui tutto, in seguito, sarà commisurato. Se ne avrà una limpida dimostrazione allorquando Vittorio Fulcoli, convalescente, cercherà di raggiungere i compagni che hanno abbandonato Monfalcone. Se l’interminabile cammino gli fa pensare che egli non “rivedrà più facce umane”, l’inaspettato incontro con un compaesano – prodigo di notizie sulla terra natia – attenueranno d’un colpo l’arduità dell’impresa.
È uno dei tanti ammonimenti disseminati nel diario, che l’autore forgia attraverso un continuo intreccio tra effimera inconsapevolezza e cattivo presagio. Non a caso le pagine del diario si aprono con la descrizione di una gioia puerile (quella prodotta dall’anticipata chiusura delle scuole dopo l’annuncio dell’entrata in guerra dell’Italia nel maggio 1915) contrapposta al presentimento di un destino incerto. Saranno i “sensi dell’uomo” a registrare un patrimonio immenso di affetti e sentimenti, al quale si dovrà più volte attingere durante la permanenza al fronte. I sapori, gli odori, le forme, i colori e le voci dell’infanzia – ripercorsi in tutta fretta la notte prima dell’addio – costituiranno il parametro principale cui tutto, in seguito, sarà commisurato. Se ne avrà una limpida dimostrazione allorquando Vittorio Fulcoli, convalescente, cercherà di raggiungere i compagni che hanno abbandonato Monfalcone. Se l’interminabile cammino gli fa pensare che egli non “rivedrà più facce umane”, l’inaspettato incontro con un compaesano – prodigo di notizie sulla terra natia – attenueranno d’un colpo l’arduità dell’impresa.
La descrizione di una natura ostile, tuttavia, è solo inversamente proporzionale all’illusione di poter vivere la guerra restandone ai margini. Più precisamente, quanto più forte è il desiderio di evitare le “complicanze belliche” tanto più il rapporto personale con la natura si fa solido, complice, diventando il principale motivo della trama narrativa. Basti pensare che quando si affiderà al caporale Fulcoli un cannocchiale per spiare nel campo nemico, egli lo userà per dare vita a una singolare descrizione dello spettacolo naturale rivelatosi ai suoi occhi. Invero natura, guerra e spettacolo vengono spesso posti dall’autore su un medesimo asse descrittivo. Si segua, ad esempio, questo passo del 12 ottobre 1916:
“Dopo la chiamata a raccolta di tutti i demoni, la grande orchestra ha iniziato il programma. La fucileria ha grandinato pallottole per qualche ora sui tetti e sui muri della città, come un miagolio straziante di gatto frustato. Nell’aria, con la morte che ronza come una voce amica, ulula la trepidazione dell’incertezza. Uniche cose viventi: il respiro affannoso dei cannoni ed il crepitare della fucileria. Alle sei del pomeriggio il ritmo è spaventoso e con esso anche la tensione dei nostri nervi. Una inconscia e bestiale allegria ci ha pervaso. Non si distingue più nulla perché sembra che una immane, gigantesca macchina stia per rendere giustizia a tutti. Anche i nostri pachidermi, dal colpo ogni mezz’ora, gareggiano nel concerto con i piccoli moscerini!”
 Va segnalato che, in un simile contesto, la presenza degli uomini viene percepita come turbatrice della bellezza del creato, apprendibile solo se osservata in solitudine. Difatti, l’umanità viene descritta come “un brusio fastidioso e volgare che si perde nelle convulsioni della natura”; i boschi, invece, vengono dipinti “come sbigottiti” per l’audacia con cui si disturba la loro secolare quiete, costruendo e disfacendo – in brevissimo tempo – “nuovi villaggi con nuovi abitatori”; il terreno, ancora, lo si vede “sconvolto da buche che sembrano precipizi”; dappertutto alberi sfrondati dai colpi di cannone, mentre da lontano il “monte Sabotino appare un galletto spennato dopo la muta e, come questo, doppiamente umiliato per l’offesa e per la cattura”. Ugualmente le trattrici, le locomotive, le automobili (finanche quelle della Croce Rossa) sono viste come particolarmente moleste, incuranti ed isteriche, per niente preoccupate dei “poveri appiedati”. Infine, anche quando si trova il tempo di salire su un costone roccioso per meglio osservare le valli sottostanti, si viene distratti dalla voce di un improvvisato cicerone che finisce col proiettare sullo sfondo l’“ombra del misterioso Lisser”, tra i teatri più funesti della Prima guerra mondiale.
Va segnalato che, in un simile contesto, la presenza degli uomini viene percepita come turbatrice della bellezza del creato, apprendibile solo se osservata in solitudine. Difatti, l’umanità viene descritta come “un brusio fastidioso e volgare che si perde nelle convulsioni della natura”; i boschi, invece, vengono dipinti “come sbigottiti” per l’audacia con cui si disturba la loro secolare quiete, costruendo e disfacendo – in brevissimo tempo – “nuovi villaggi con nuovi abitatori”; il terreno, ancora, lo si vede “sconvolto da buche che sembrano precipizi”; dappertutto alberi sfrondati dai colpi di cannone, mentre da lontano il “monte Sabotino appare un galletto spennato dopo la muta e, come questo, doppiamente umiliato per l’offesa e per la cattura”. Ugualmente le trattrici, le locomotive, le automobili (finanche quelle della Croce Rossa) sono viste come particolarmente moleste, incuranti ed isteriche, per niente preoccupate dei “poveri appiedati”. Infine, anche quando si trova il tempo di salire su un costone roccioso per meglio osservare le valli sottostanti, si viene distratti dalla voce di un improvvisato cicerone che finisce col proiettare sullo sfondo l’“ombra del misterioso Lisser”, tra i teatri più funesti della Prima guerra mondiale.
 Si comprende bene che il ricorso alla metafora e all’ironia qualificano frequentemente il discorso autobiografico, ma è il sentimento cristiano che sopra ogni cosa ne orienta lo sviluppo. Dopotutto, fin dal principio, il viaggio attraverso la guerra viene definito “ieratico”; una scelta terminologica precisa, che in un certo qual modo anticipa simbolicamente le scene di un martirio che sia il corpo sia l’anima saranno costretti a subire. Il lettore analizzi con attenzione la visita che Vittorio Fulcoli compie alle trincee devastate dalla furia omicida: una moltitudine di corpi, che si ha timore a scavalcare; il “rosso sparso”, che non si ha il coraggio di chiamare sangue; un’infinità di oggetti abbandonati, cose da poco eppure “reliquie” agli occhi di chi osserva. E poi le mille domande che pesano come macigni sulla coscienza: quale storia avrebbero potuto raccontare quei soldati così brutalmente offesi? per quali ideali essi sono veramente morti? come è possibile non avere pietà per i cadaveri di cui sono “costellati i reticolati”? e poi quale destino attenderà i cari abbandonati per sempre? “Si potrebbe arrivare fino alle lacrime ma nulla cambierebbe”, confida a se stesso il caporale affranto, in uno dei pochi momenti in cui l’incrollabile fede sembra vacillare. Il soldato, felice per essere ancora nella schiera dei sopravvissuti, coglie un fiore. Capisce così che la speranza di ritrovare la propria vita, recidendo quella altrui, è vuota e superficiale. Una sensazione già sperimentata quando egli, comprando alcune cartoline da una vecchietta di Gallio, ebbe il timore di averle rubato vita e ricordi. D’altra parte, si osserva, la guerra abitua i malcapitati avventori al susseguirsi di repentine contraddizioni!
Si comprende bene che il ricorso alla metafora e all’ironia qualificano frequentemente il discorso autobiografico, ma è il sentimento cristiano che sopra ogni cosa ne orienta lo sviluppo. Dopotutto, fin dal principio, il viaggio attraverso la guerra viene definito “ieratico”; una scelta terminologica precisa, che in un certo qual modo anticipa simbolicamente le scene di un martirio che sia il corpo sia l’anima saranno costretti a subire. Il lettore analizzi con attenzione la visita che Vittorio Fulcoli compie alle trincee devastate dalla furia omicida: una moltitudine di corpi, che si ha timore a scavalcare; il “rosso sparso”, che non si ha il coraggio di chiamare sangue; un’infinità di oggetti abbandonati, cose da poco eppure “reliquie” agli occhi di chi osserva. E poi le mille domande che pesano come macigni sulla coscienza: quale storia avrebbero potuto raccontare quei soldati così brutalmente offesi? per quali ideali essi sono veramente morti? come è possibile non avere pietà per i cadaveri di cui sono “costellati i reticolati”? e poi quale destino attenderà i cari abbandonati per sempre? “Si potrebbe arrivare fino alle lacrime ma nulla cambierebbe”, confida a se stesso il caporale affranto, in uno dei pochi momenti in cui l’incrollabile fede sembra vacillare. Il soldato, felice per essere ancora nella schiera dei sopravvissuti, coglie un fiore. Capisce così che la speranza di ritrovare la propria vita, recidendo quella altrui, è vuota e superficiale. Una sensazione già sperimentata quando egli, comprando alcune cartoline da una vecchietta di Gallio, ebbe il timore di averle rubato vita e ricordi. D’altra parte, si osserva, la guerra abitua i malcapitati avventori al susseguirsi di repentine contraddizioni!
In conclusione appare quasi superfluo aggiungere che non mancano nel diario del Fulcoli significativi giudizi di valore, in senso lato politici, che troveranno nell’epilogo una valida sintesi. Ne propongo qui una specifica selezione: “La guerra è meno paurosa viverla che osservarla o raccontarla”, si troverà scritto in un’annotazione dal Fiara; e da Gorizia, poco dopo, si scriverà: “Case distrutte, campagne frantumate… desolazione e voci di dolore, imprecazioni, spasimi: nessuno vede e ascolta?”. Similmente, a seguito dell’incontro casuale con un soldato “amante” della guerra, si annoterà: “Quell’uomo mi ha disgustato. Me ne sono allontanato rattristato pensando che la canzone di Trieste con le relative campane di San Giusto sono una trappola”. Un criterio di valutazione che l’autore non esita ad applicare agli alleati, ai comandanti italiani e ai raccomandati nell’esercito. Un giudizio altrettanto forte viene espresso sui giornali e sulle modalità di costruzione dell’opinione pubblica. Non si manca inoltre di mettere sotto accusa lo spirito di “revanche”. Infine, in una lettera al padre, scorgiamo la notizia delle stragi compiute sull’Hermada.
Splendida l’osservazione conclusiva rivolta ai genitori: “Se poteste semplicemente immaginarvelo il dramma della guerra”; osservazione che suona come potente invito a una riflessione profonda sulla condizione umana (Riproduzione riservata©).
Scheda: Vittorio Fulcoli, «Amici e nemici, addio». Ricordi della Prima guerra mondiale, a cura di Alfonso Fulcoli, Narrazioni, 1, 2009 [pp. 9-143 / ISBN 9788864360478]